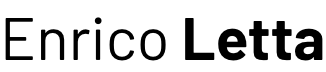In bilico tra passato e progresso. Quel ponte per il dopo crisi
 Intervento di Enrico Letta su “la Lettura – Corriere della Sera” del 27 ottobre 2013.
Intervento di Enrico Letta su “la Lettura – Corriere della Sera” del 27 ottobre 2013.
Jacques Cœuer, l’eroe del bellissimo L’uomo dei sogni di Jean-Christophe Rufin, è un figlio di artigiani che diventa l’uomo più potente di Francia. Inventa la finanza moderna, ma – anziché farne strumento fine a se stesso, di accumulo – la usa come leva per creare lavoro. Testimone di un passaggio d’epoca, dal Medioevo al Rinascimento, sceglie l’apertura e lo scambio contro una società europea immobile che ancora interpretava il rapporto con l’altro come crociata e chiusura.
Al pari di Cœuer anche noi viviamo un’epoca “liminare”, in bilico tra privilegio e progresso, tra passato e cambiamento. La parabola della crisi, in Europa e dell’Europa, bene sintetizza questa transizione.
Una transizione segnata da una prima cesura. È il “whatever it takes” di Mario Draghi. È il 25 luglio 2012. In una conferenza stampa destinata a farsi spartiacque della storia europea, l’ex governatore della Banca d’Italia rassicura il mondo e i mercati: la BCE farà tutto il necessario per salvare l’euro. Tre parole per scongiurare il default degli Stati a rischio. Tre parole per “scrivere” il prologo della svolta.
Dai primissimi segnali di crisi a quella conferenza stampa è trascorso circa un quinquennio. Nelle stesso periodo si sono susseguiti 27 Consigli europei: quasi tutti infruttuosi. Fino al “whatever it takes” dinanzi al collasso dell’equilibrio tra finanza ed economia reale sono parsi saltare i convincimenti degli economisti e i cardini stessi dell’economia di mercato.
Nel frattempo l’onda, lontano, montava. La metafora, benché abusata, racconta efficacemente quanto sarebbe avvenuto di lì a non molto. Urto devastante, smarrimento, inadeguatezza nella gestione dell’emergenza. Alla maniera dei cataclismi l’impatto in Europa è stato più forte laddove i sistemi erano più deboli. Di fronte a tutto questo abbiamo all’inizio contemplato le macerie. Come in attesa che il peggio passasse. Oppure come quando – e prendo in prestito le parole di Edmondo Berselli – ci si aspetta che “dal mare riaffiorino, roteando lentamente, i relitti di un naufragio”.
Col tempo saremo forse in grado di capirlo meglio, questo naufragio. Le analisi, del resto, si moltiplicano. Massimo Gaggi ha illustrato, ad esempio, qui su La Lettura le sfumature del dibattito pubblico americano sull’erosione del ceto medio, sul moltiplicarsi delle disuguaglianze, sul legame tra crisi, globalizzazione, tecnocrazia. Si chiede, Gaggi – ed è l’interrogativo centrale che mi ha indotto a scrivere questo intervento – quali siano i margini d’azione della politica. Semplicemente pregare che arrivi la ripresa, come rimprovera ai governi King, oppure “sporcarsi le mani”, immergersi nella complessità di fenomeni epocali, assumere una volta per tutte la consapevolezza – per dirla con Tony Judt – che le disuguaglianze sono “corrosive”?
È vero: la disuguaglianza sgretola la società perché la fa marcire al proprio interno. E, come sostiene Vittorio Emanuele Parsi nel suo saggio sulla fine dell’uguaglianza, essa ha effetti devastanti sulla convivenza civile, minando alla base sia la democrazia sia il mercato. Per questo l’ultima cosa che deve fare la politica, in Italia e in Europa, è rimuovere la realtà e rifugiarsi nelle scorciatoie, magari rispolverando antinomie ormai insufficienti come quella tra Stato e mercato. Non è più in discussione la preminenza dell’uno sull’altro. In discussione c’è la costruzione di un nuovo “canone” che dai relitti del naufragio della crisi sia in grado di recuperare l’unico pezzo davvero insostituibile – il nesso tra democrazia rappresentativa, economia di mercato, welfare – per renderlo compatibile con la trasformazione in atto nel mondo: con la rivoluzione tecnologica, con l’emersione di nuovi protagonisti dell’economia globale, con l’invecchiamento della popolazione.
A dispetto di tante ottime ricognizioni, da noi l’eco di questo dibattito globale arriva attenuata. Per le responsabilità – innegabili – della politica e per i limiti di tutto il sistema della rappresentanza. Ci tormentiamo, dividendoci, con la presunta contesa tra “principi” e “interessi”, dimenticando che essi – come ci ha ricordato qualche tempo fa Eugenio Scalfari – viaggiano insieme. Perché i primi, senza ancoraggio alla realtà, sono velleità utopiche, mentre i secondi, in mancanza del senso di una missione condivisa, perpetuano il privilegio ed esasperano la polarizzazione della ricchezza.
Per quanto mi riguarda, non posso che ripetere e cercare di dimostrare coi fatti che l’unica strada per conciliare “valori” e “interessi” è costruire un “ponte” tra l’Italia della crisi e quella del dopo-crisi. Anche noi, come Cœuer e come l’Europa, siamo in una dimensione apparentemente scardinata tra passato e futuro: viviamo oggi gli strascichi (e le macerie) di un terremoto generatosi anni fa, e dunque nel passato, ma non viviamo ancora, e soprattutto non percepiamo, gli effetti di un processo già iniziato, l’uscita dalla crisi, destinato a manifestarsi compiutamente solo nel futuro prossimo.
Questo ponte deve essere solido e costruito con serietà, mattone su mattone. Questo ponte poggia su due piloni: la “stabilità” e la “comunità”. La stabilità come cambiamento essa stessa, perfino come una rivoluzione in una democrazia, quale quella italiana, endemicamente incline alla provvisorietà e all’incertezza; valore in sé e condizione indispensabile per programmare gli interventi necessari a modernizzare il Paese, liberandosi finalmente dall’ossessione del consenso immediato, che impedisce qualsiasi cambiamento strutturale. E la comunità come risposta a una società frantumata e divisa tra pochi privilegiati e una sottoclasse fatta di persone lasciate sole e di “rassegnati” di tutte le età.
Il punto è che il nostro non è uno “Stato fallito”, ma certo è uno “Stato fragile”, da maneggiare con cura, alle prese con l’eredità di un debito pesantissimo, reduce da una crisi di fiducia prima di tutto in se stesso e poi sui mercati internazionali, segnato da ferite molto profonde, ancora aperte, nella vita dei cittadini e anche nella propria cultura politica.
Un Paese incerto dove, a dispetto della retorica, le grandi riforme da fare qui e subito sono tanto facili da declamare a parole quanto complesse e faticose da attuare nei fatti. Un Paese dove sugli squilibri storici (sociali, geografici, tra generazioni) si sono sedimentate nuove e dilaganti forme di vulnerabilità e disagio. E il disagio, se inascoltato o malinteso, si trasforma in indignazione, l’indignazione in rabbia, la rabbia in conflitto sociale.
È questa l’equazione che Grillo e Casaleggio hanno intuito meglio e prima di tutti, precursori di una singolare miscela di populismo e illusioni da democrazia diretta. Una miscela che senza la duplice crisi, economica e politica, non sarebbe stata pensabile ma che trova oggi sorprendenti “gemellaggi” nel mondo. Cosa sarebbe stato lo shutdown brandito dal Tea Party negli Stati Uniti e fortunatamente superato se non un gigantesco, drammatico, V-day nella variante americana? Il trionfo della logica del conflitto su quella dell’interesse nazionale, la fine della comunità vissuta come insieme di persone unite da valori, interessi, storia, istituzioni.
È l’inverso di quella che, a mio parere, dovrebbe invece essere la prima lezione della crisi: il rifiuto del metodo del conflitto e il recupero della “relazione” così come emerge da una lettura dell’Enciclica Caritas in Veritate fondata sull’homo relatus. La nostra comunità non può più concedersi il lusso di lasciare qualcuno indietro. E ciò non per un nostalgico afflato di egualitarismo omologante ma per necessità, direi per convenienza: per essere più forte e competitiva, per non pagare ancora il prezzo delle disuguaglianze che si allargano e divengono sempre più incolmabili, disegnando il profilo di una società bloccata, immobile, senza equità né speranza. Diseguaglianze che, come racconta Gaggi, rischiano di travolgere il cuore stesso dell’Occidente, quel ceto medio protagonista, in passato, di decenni di progresso ininterrotto e che oggi, per paradosso, proprio del progresso tecnologico rischia di pagare il conto più salato.
A ben vedere, c’è, in questa accezione di comunità e di relazione, anche molto del senso del “whatever it takes” di Draghi, nonché la sfida più ambiziosa che attende l’Ue nei prossimi mesi. Anche nell’Europa del dopo-crisi nessuno può rimanere indietro: vale per gli Stati membri in difficoltà, vale per le disuguaglianze tra Paesi e dentro i Paesi. Solo se l’Europa è realmente unita e solidale anche su questo può, richiamando le parole del capo dello Stato Napolitano al meeting di Rimini, evitare di finire “sommersa” dalle trasformazioni della contemporaneità. E solo così si può richiedere con maggiore credibilità alle persone e agli Stati di rispettare le regole, di condividere le responsabilità, di essere aperti al confronto e alla competizione. Solo così, tornando a un’altra complessa transizione, si può passare dall’austerità alla crescita e anche, più in prospettiva, da un modello di welfare esemplare ma non più sostenibile a un paradigma di redistribuzione della ricchezza e del benessere nuovo anche se ancora da definire.
È l’Europa democratica da costruire. A partire dal completamento, effettivo senza più esitazioni, delle unioni bancaria, fiscale, economica, politica. Per farcela dobbiamo condurre una battaglia, appunto, politica: cedere – e far cedere – sovranità nazionale, per essere parte di una nuova sovranità sovranazionale, europea. Questa battaglia si vince democraticamente: dobbiamo persuadere i cittadini europei che dare vita all’unione politica non è avere nuovi vincoli, ma, al contrario, produrre politiche uniformi per il sostegno all’occupazione o dare possibilità di impiego e riconoscimento dei talenti oggi dispersi e frustrati. Gli europei, sì. Fare l’Europa è oggi “fare gli europei” e colmare così la distanza enorme tra l’europeismo convinto di intellettuali e politici e la vita reale dei cittadini. Significa battere i populismi con l’Europa “popolare”, cioè col consenso dei popoli. Significa trovare risposte di governo. Per questo dobbiamo portare, come stiamo facendo, anche a livello europeo alcune priorità che ci siamo dati, in questi mesi, per il nostro Paese: lavoro, welfare, istruzione, ambiente, innovazione, agenda digitale.
Ci impegneremo su questo e lo faremo vivendo il semestre di Presidenza italiano dell’Unione come l’occasione per guidare il percorso verso il cambiamento. Lo furono, per motivi diversi, i semestri del 1985, col Consiglio di Milano che pose le basi per l’Atto Unico Europeo, e quello del 1990 che, con il Consiglio di Roma, spianò la strada a Maastricht.
Oggi se possibile la posta in palio è ancor più alta. È l’opportunità, unica, di dare corpo e sostanza – magari con lo stesso spirito di Cœuer e fors’anche con la stessa leggerezza – al più grande progetto politico delle nostre generazioni: gli Stati Uniti d’Europa.