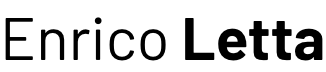Non aspettiamo che la casa bruci
 Colloquio con Enrico Letta di Marco Damilano, l’Espresso, 1 luglio 2016
Colloquio con Enrico Letta di Marco Damilano, l’Espresso, 1 luglio 2016
«La classe dirigente non c’è più. Le élite non esistono più…». Comincia la conversazione con Enrico Letta, non un a pocalittico ma l’ex presidente del Consiglio, ora a Parigi come direttore di Sciences Po, nel cuore dell’Europa a rischio dissoluzione dopo il referendum inglese. Un punto di osservazione privilegiato: «Per me è stato un anno fondamentale», racconta. «Mille giovani da tutto il mondo ti fanno leggere la realtà in modo diverso. Per questa generazione è in discussione il ruolo stesso della politica. I ragazzi che non sono andati a votare sulla Brexit dimostrano che per loro la vita non passa più da lì». «Credo che il rilancio dell’Europa sia decisivo -ripete l’ex premier – Anche l’attentato di Istanbul dimostra che la parola chiave di questo tempo è protezione e non protezionismo. C’è bisogno di un’Europa che protegga i suoi cittadini, le fasce deboli, i perdenti della globalizzazione».
Come si spiega una frattura così profonda tra una parte della società e l’establishment politico, economico, culturale, mediatico che ha la pretesa di guidarla? «Negli ultimi cinque anni è finita la verticalizzazione della società. Tra big data, internet, le crisi legate alle migrazioni e al terrorismo, è venuta meno l’organizzazione che ha costruito i gruppi dirigenti del passato. Prima ce ne rendiamo conto, meglio è. Solo da questa presa d’atto potremo dare un senso, un’efficacia alla richiesta di orizzontalità del nostro tempo. Vedo che invece il dibattito in Europa continua ad attardarsi su chi ha il potere, chi comanda, come aumentare la velocità di decisione di chi sta al vertice. Le ritengo discussioni cancellate dall’impatto con i nuovi fenomeni, epocali».
L’ex primo ministro gollista francese Alain Juppé, probabile candidato alle presidenziali del 2017, dice che la frattura pro o contro Europa cancella la divisione tra destra e sinistra… «Sono d’accordo. E le ultime elezioni rivelano altre fratture. Tra centro e periferia. E tra chi ha il passaporto e chi non ce l’ha, o meglio non lo usa. Tra chi beneficia dei vantaggi della globalizzazione e chi ne avverte solo gli effetti negativi. Per me il saldo è positivo: in un tempo breve un miliardo di persone in Asia è uscito dalla povertà estrema. Ma dal punto di vista occidentale si avverte con più forza la crescita delle disuguaglianze nelle nostre società. Gli esclusi non si sentono rappresentati e reagiscono con rabbia. E la politica rischia di reagire con la soluzione sbagliata: più verticalizzazione nelle decisioni e nel potere».
Ma non si è sempre detto che una delle cause della crisi europea è l’assenza di una leadership politica forte? «Sì, ma il punto è: che qualità deve avere una leadership? Oggi la crisi delle élite esalta la necessità di unire, non di semplificare. Servono leader che uniscano, non leader che semplificano e dividono. Quando semplifichi, a furia di cancellare e di tagliare ogni complessità, arriva qualcuno che semplifica più di te e che alla fine ti manda a casa. Per questo la crisi scuote in particolare i sistemi presidenziali, i più verticali. Vivo in Francia, in questo momento il paese più shakerato d’Europa. Non si può ridurre il campo fino a una scelta o di qua o di là quando c’è un tripartitismo o addirittura un quadripartitismo. Può reggere negli Stati Uniti dove c’è un bipartitismo, ma nei Paesi europei è una forzatura eccessiva. Vale anche per l’Italia: voler introdurre un sistema simil-presidenziale come quello che esce dall’Italicum è un errore profondo, una spinta artificiale che provocherà gli stessi danni di cui soffrono oggi altri Paesi europei. I sistemi presidenziali ti danno la forza, ma non ti obbligano a includere. E invece questo è il tempo di unire. Di fare coalizioni».
Lei ha guidato un governo di larghe intese tra il Pd e il Pdl e non è andata bene. In Germania la grande coalizione con Angela Merkel ha annichilito i socialdemocratici, ora si ipotizza in Spagna tra popolari e socialisti. È questo il futuro: grandi coalizioni contro partiti anti-sistema? «La grande coalizione può essere una soluzione eccezionale, emergenziale, ma se diventa stabile si trasforma in un vantaggio per chi resta fuori, per chi lucra sul fatto di non essere in quello schema. Non credo che la soluzione sia l’alleanza tra le famiglie politiche sopravvissute al Novecento, i socialisti e i popolari. È una reazione difensiva, che non attrae nessuno, perdente. Il vino nuovo non può stare negli otri vecchi, servono discontinuità di tipo politico e organizzativo».
Ma non avevate fondato il Pd per questo motivo, per superare le identità politiche tradizionali? Lo avete ripetuto per anni… «Prima del Pd è venuto l’Ulivo. Innovazioni della politica italiana che hanno anticipato l’Europa. Ora non si può continuare a fare finta che non sia successo nulla o continuare a evocare parole fuorvianti come populismo».
Perché fuorvianti? «Perché catalogare sotto lo stesso concetto il partito di Marine Le Pen e il Movimento 5 Stelle è onestamente sbagliato. È un’analisi che non ci fa capire come stanno le cose e che ci porta a conclusioni paradossali. Davvero il 67 per cento degli elettori romani che ha votato per Virginia Raggi si può definire in blocco populista? È una frattura che va chiamata con il suo nome: partiti tradizionali da una parte, forze politiche nuove dall’altra».
Vecchio contro nuovo? «Io vedo due errori: identificare la grande coalizione come l’accordo dei vecchi partiti. Oppure puntare sulla verticalizzazione del potere, in un momento in cui i nuovi movimenti affermano la necessità di riaprire le élite, i circuiti chiusi in cui non si entra senza la cooptazione. In Italia M5S è riuscito a inserire gli outsider nel gioco della politica, è questo il merito che gli riconoscono gli elettori. Che il tema sia centrale lo dimostra la campagna elettorale americana: noi giriamo attorno alla crisi di Bruxelles e della Ue, ma in Usa non ci sono invasioni di rifugiati e disoccupazione giovanile, eppure dominano Trump e Sanders, gli outsider. Con tutti i loro limiti, aggiungo. Il caso inglese è emblematico anche da questo punto di vista. Nel Labour Party i fratelli Ed e David Miliband, il meglio della classe dirigente, i talenti coltivati con cura, si sono eliminati a vicenda. Dopo di loro la base ha scelto Jeremy Corbyn, l’outsider per eccellenza. E alla prima prova, nel momento cruciale, il voto sulla Brexit che segnerà la storia del suo Paese e dell’Europa, si è reso corresponsabile di un evento di dimensioni planetarie. La sua inadeguatezza ha contribuito a produrre uno sfascio non solo per il suo partito, ma per tutti».
E l’outsider bravo? Esiste? Immagino che non indicherà un ragazzo venuto da Rignano sull’Arno… «Dico lo spagnolo Albert Rivera, leader di Ciudadanos. Mi sembra un giovane politico che prova ad affermare una novità e che si propone come affidabile».
La sfiducia ha corroso le élite. A Roma chi ha votato la Raggi ha detto: un salto nel vuoto, ma degli altri non mi fido più. «Siamo entrati nel tempo di San Tommaso. Nella società mediatica credi solo a quello che vedi e che tocchi con mano. Non ti fidi della tradizione orale, meno che mai degli esperti e dei politici. E sei disposto ad accettare decisioni complesse, dolorose, coraggiose, solo quando la casa brucia. Il guaio è che a quel punto è tardi: la casa è già bruciata. Non dubito che ora molti inglesi, se potessero, voterebbero per il “remain”. Ma nel voto è prevalsa la voglia di dare una lezione a David Cameron, a Oxford, Cambridge e la City».
Che classe dirigente è quella che si rifiuta di decidere e che scarica sui cittadini la scelta? Ieri Tsipras con il referendum in Grecia, oggi Cameron con il Brexit, domani la Raggi sulle Olimpiadi a Roma… «A una dinamica di deresponsabilizzazione si può rispondere solo con un soprassalto di responsabilità. Dire ai cittadini, in modo pubblico, diretto: ho deciso e se le cose andranno male ne prenderò atto».
Non è quello che dice di voler fare Renzi con il referendum sulla Costituzione? «No, è stato un errore personalizzare il referendum, mettere insieme piani diversi: la riforma costituzionale, la vita del governo, il futuro del leader. Un errore clamoroso che può provocare altre ripercussioni. E nuovi danni».
Si può rimediare? «I francesi dicono: non si rimette la schiuma nello spray. È complicato, ma decisivo per evitare altri sconquassi. Non sarebbe sbagliato pensare a spacchettare la riforma in più quesiti, per permettere agli elettori di discutere i singoli punti: il Senato, le regioni, come si fanno le leggi…».
Oppure si cambierà la legge elettorale? «L’Italicum non andava fatto. Il mio ultimo atto da deputato è stato votare contro una legge che è come il Porcellum. Renzi l’ha voluta su misura di sé e del Pd al 40 per cento. Difficile tornare indietro, anche perché sembrerebbe di farlo contro M5S. Ma votare con l’Italicum sarebbe irresponsabile».