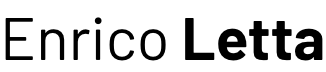PD, un’idea di futuro e di comunità
Intervento pubblicato su «l’Unità», il 24 ottobre 2010
Berlusconi è un “capo popolo”. È quello che vince le elezioni. Berlusconi non è un “capo di governo”. La macchina dell’esecutivo la guidano altri al posto suo, ma nessuno di loro sarà mai in grado di vincere. Questa distinzione – tra chi il consenso lo conquista e chi deve poi adempiere alla funzione di governo che da quello stesso consenso è originata – costituisce, tra le tante degenerazioni berlusconiane, quella che più subdolamente, da due anni a questa parte, sta scavando nell’essenza stessa della democrazia italiana. È una questione che non va confusa con la mera conseguenza delle attitudini personali del presidente del Consiglio, ma che attiene alla costruzione e al consolidamento della leadership, tema di cui tanto si discute anche nell’eterno dibattito interno al Partito Democratico.
Giovedì scorso, nell’analisi di Alfredo Reichlin sulle macerie dell’Italia berlusconiana, abbiamo letto il giusto richiamo ad allargare lo sguardo oltre le nostre piccole dispute quotidiane, per vedere quali epocali trasformazioni si stanno verificando, in Europa e nel mondo, sotto il cielo della globalizzazione e della crisi. Abbiamo letto la rivendicazione legittima del ruolo che spetta al PD in questa difficilissima stagione, insieme all’appello a farci, noi democratici prima degli altri, portatori di un’idea del bene comune fondata sulla giustizia sociale, nella consapevolezza della complessità della contemporaneità, dell’asprezza dei conflitti, dell’obsolescenza delle vecchie categorie ideologiche nelle quali troppo spesso qualcuno continua a inciampare.
Ciò che è mancato in questi quindici anni di centrosinistra – fatta eccezione per la prima stagione dell’Ulivo – è stata in effetti la forza di proporre al Paese un’idea condivisa di futuro e di comunità. È mancata per le troppe energie sprecate a dividerci su iscritti ed elettori, papi stranieri e papi casalinghi, CGIL e CISL, prosa e poesia. Ma è mancata soprattutto perché, nel tentativo spesso genuino di dare alla società ciò che supponevamo essa si attendesse da noi, non ci siamo accorti che proprio la società ci cambiava sotto il naso, contagiata, certo, dal virus berlusconiano ma anche brava a scoprire in sé gli anticorpi giusti, sempre più esigente nei confronti della politica, legittimamente disillusa a causa delle nostre tante, ingiustificabili, occasioni mancate.
Così, concentrati sulla capacità di narrazione di Berlusconi, non abbiamo compreso che la forza del messaggio stava anche nella sua abilità di interpretazione del Paese: nell’analisi, spesso addirittura sofisticata, dei bisogni e delle aspettative dei cittadini. Per questo non possiamo sorprenderci se poi la fortezza berlusconiana del consenso abbia cominciato a sgretolarsi proprio quando i cittadini – i milioni che lo hanno sostenuto e che noi abbiamo sovente snobbato, dimenticando che anche tra di loro c’erano (e ci sono) i “deboli” e gli “ultimi” – hanno capito che quelle aspettative e quei bisogni non sarebbero mai stati soddisfatti.
La chiave sta tutta qui: nella schizofrenia di un “capo popolo” che non ha saputo farsi “capo di governo”. Neanche a Berlusconi è bastata la narrazione. E l’interpretazione gli è servita fintantoché i nodi – l’inefficacia della sua azione di governo più ancora della sua inqualificabile condotta personale – non sono venuti al pettine. Ora è fondamentale non commettere gli stessi errori e non precipitare, anche in buona fede, nella trappola dell’emulazione berlusconiana. La narrazione serve ma non è sufficiente. L’interpretazione serve ma non è sufficiente. Paradossalmente anche i numeri – e il centrodestra ne aveva abbastanza per “rivoltare” il Paese da cima a fondo – servono ma non sono sufficienti. Questo perché manca sempre l’ultimo passaggio, il più importante, quello che dà senso al riformismo e che fa della politica – mai come oggi, con il Paese coperto di “macerie” – la più nobile tra le attività umane, l’unica che ci può consentire di risolvere i problemi delle persone e di ricostruire il futuro della nostra comunità.
Per comprenderlo, questo passaggio, pensiamo alla differenza tra la politica e le politiche, tra politics e policies. Sembra una distinzione di poco conto, di banale declinazione grammaticale, e invece racchiude in sé il cuore del nostro progetto. Partiva, non a caso, da questa elementare classificazione politologica la riflessione che più frequentemente Nino Andreatta ci proponeva a proposito della identità democratica. Le politiche – la capacità di programmarle, attuarle, monitorarne l’efficacia – devono essere la nostra politica. Le politiche devono rappresentare la vera, inderogabile, discriminante nella scelta delle nostre alleanze e dei nostri compagni di viaggio. Ciò vuol dire che ogni azione, ogni proposta, ogni iniziativa amministrativa o legislativa deve essere indirizzata solo e soltanto a un obiettivo, che nel nostro caso è rappresentato da un modello di società più giusta e aperta, più coesa e competitiva. Tutto ciò entro il quadro di una promozione dell’interesse generale che abbia come priorità la risoluzione dei problemi e il soddisfacimento delle aspettative dei cittadini, dal primo all’ultimo. O meglio: dall’ultimo al primo, per ricordare ancora Andreatta.
C’era già, in questa iniziale intuizione dell’Ulivo e del PD, il richiamo a superare la visione classista della società italiana, lasciandosi alle spalle linguaggi, chiese, interlocutori di riferimento tipici dell’identità statica del Novecento, per definirne una nuova di identità, più dinamica e originata non dalla sintesi astratta delle appartenenze del passato, ma dalla declinazione concreta delle proposte per il futuro. È il programma delle politiche che dà forma al progetto. E non perché – come qualcuno obietta – manchi la politica (al singolare), ma perché la politica come l’abbiamo vissuta per decenni non esiste più o quanto meno non si fa più in funzione della carta d’identità che abbiamo in tasca, ma in nome dell’idea di futuro che abbiamo in mente.
Negli ultimi anni questo richiamo a superare i codici di comportamento politico del Novecento non ha avuto la forza di tradursi in un riformismo coerente, fatto di spinte ideali e pragmatismo. La traduzione adesso dobbiamo farla noi. Ma per farla bene dobbiamo essere il più possibile credibili sul piano dell’etica e della responsabilità pubblica, praticando e pretendendo rigore assoluto prima di tutto al nostro interno. Il più possibile autorevoli e competenti nella comprensione della società e nella elaborazione delle politiche. Il più possibile autonomi dalle forze sociali e dalle rappresentanze d’interessi. Fors’anche il più possibile autonomi dai noi stessi, dai tic istintivi delle nostre trascorse appartenenze.
È vero: qui o si rifa l’Italia o l’Italia muore. E muore perché soffoca, ma soffoca tutta: non una sola parte, né una sola categoria di cittadini. Soffoca la speranza del ricercatore calabrese che abbandona il Paese perché un sistema baronale e asfittico non lo mette in condizione di far brillare il proprio talento e non gli dà una sola opportunità di dimostrare quanto vale. Soffoca la voglia di vivere del piccolo artigiano di Rovigo, umiliato da creditori inadempienti e costretto, lui pure, a chiudere i battenti, rinunciando non a inutili benefit ma all’aspirazione sacrosanta di garantire ai propri figli un’istruzione come si deve. Soffoca la dignità dell’operaio specializzato cassintegrato di Termini Imerese insieme a quella dell’imprenditrice brianzola, che, pur di non licenziarli, anticipa di tasca propria i compensi per i suoi 5 dipendenti. Soffoca la fiducia nello Stato dell’impiegata milanese spaventata perché costretta la sera a percorrere strade poco sicure, come pure quella del giovane immigrato di seconda generazione che non riesce a fare impresa perché oggetto di ignobili discriminazioni.
Chi di loro è il vero “eroe dei nostri tempi”? Ha senso chiederselo per elargire stucchevoli “patenti di eroismo” oppure non è meglio lavorare tutti e subito alla svolta di cui ha bisogno il Paese? Una svolta fatta di politiche: di idee, sollecitazioni, creatività, innovazione, proposte coraggiose e dirompenti. Per questo è così importante il percorso sulla costruzione dei contenuti dell’Assemblea Nazionale del PD scandito dalle tappe di Roma, Varese e Napoli.
E in questo percorso dobbiamo muoverci in direzione di un unico obiettivo, ma chiaro e altissimo: lo sviluppo, pieno e inteso in ogni sua articolazione. Lo sviluppo indispensabile per colmare le fratture drammatiche tra lavoro e ricchezza e tra economia e società aggravatesi con la crisi, come è scritto nel testo, forse più citato che letto, dell’Enciclica Caritas in Veritate. Lo sviluppo che è un dovere e non un lusso. Un dovere che appartiene prima di tutto al Partito Democratico